Palomma e Notte
- Home
- Le Canzoni
- Palomma e Notte
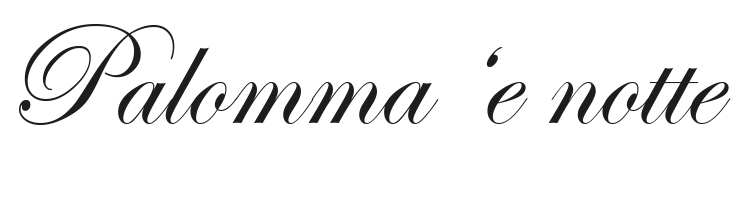

Testo della canzone
Tiene mente ‘sta palomma,
Comme ggira, comm’avota,
Comme torna ‘n’ata vota
‘Sta ceroggena a ttentà!
Palummè, chist’è ‘nu lume,
Nun è rosa o giesummino,
E tu a fforza ccà vvicino
Te vuò mettere a vulà!
Vattenne ‘a lloco!
Vattenne, pazzarella!
Va’, palummella, e torna,
E torna a ‘st’aria
Accussì fresca e bella!
‘O bbì ca i’ pure
Mm’abbaglio chianu chiano,
E ca mm’abbrucio ‘a mano
Pe’ te ne vulè caccià?
Carulì, pe’ ‘nu capriccio,
Tu vuò fà scuntento a ‘n’ato
E po’, quanno ll’hê lassato,
Tu, addu ‘n’ato, vuò vulà.
Troppe core staje strignenno
Cu ‘sti mmane piccerelle;
Ma fernisce ca ‘sti scelle
Pure tu te può abbrucià.
Vattenne ‘a lloco!
Vattenne, pazzarella!
Va’, palummella, e torna,
E torna a ‘st’aria
Accussì fresca e bella!
‘O bbì ca i’ pure
Mm’abbaglio chianu chiano,
E ca mm’abbrucio ‘a mano
Pe’ te ne vulè caccià?
Torna, va’, palomma ‘e notte,
Dint’a ll’ombra addò sì nnata!
Torna a ‘st’aria ‘mbarzamata
Ca te sape cunzulà!
Dint’ ô scuro e pe’ mme sulo
‘Sta cannela arde e se struje,
Ma c’ardesse a tutt’ ‘e dduje,
Nun ‘o ppozzo suppurtà!
Vattenne ‘a lloco!
Vattenne, pazzarella!
Va’, palummella, e torna,
E torna a ‘st’aria
Accussì fresca e bella!
‘O bbì ca i’ pure
Mm’abbaglio chianu chiano,
E ca mm’abbrucio ‘a mano
Pe’ te ne vulè caccià?
Testo della canzone tradotto
Guarda questa farfalla,
Come gira, come svolazza,
Come torna un’altra volta
A tentare questa candela!
Farfallina, questo è un lume,
Non è rosa o gelsomino,
E tu per forza qua vicino
Ti vuoi mettere a volare!
Vattene da là!
Vattene, pazzerella!
Va’, farfallina, e torna,
E torna a quest’aria
Così fresca e bella!
Lo vedi che anch’io
Mi abbaglio piano piano,
E che mi brucio la mano
Per volerti cacciare via?
Carolina, per un capriccio,
Tu vuoi fare scontento un altro
E poi, quando l’hai lasciato,
Tu, da un altro, vuoi volare.
Troppi cuori stai stringendo
Con queste tue mani piccole;
Ma finisce che queste ali
Anche tu ti puoi bruciare.
Vattene da là!
Vattene, pazzerella!
Va’, farfallina, e torna,
E torna a quest’aria
Così fresca e bella!
Lo vedi che anch’io
Mi abbaglio piano piano,
E che mi brucio la mano
Per volerti cacciare via?
Torna, va’, farfalla di notte,
Nell’ombra dove sei nata!
Torna a quest’aria profumata
Che ti sa consolare!
Nel buio e solo per me
Questa candela arde e si strugge,
Ma che arda tutti e due,
Non lo posso sopportare!
Vattene da là!
Vattene, pazzerella!
Va’, farfallina, e torna,
E torna a quest’aria
Così fresca e bella!
Lo vedi che anch’io
Mi abbaglio piano piano,
E che mi brucio la mano
Per volerti cacciare via?
Esposizione commentata e ambientazione
Palomma ‘e notte è una poesia scritta per diventare musica, con tre coppie di quartine intervallate da un ritornello, per lo meno nella sua versione definitiva al culmine di una complicata storia editoriale. Adottato l’arrangiamento di Francesco Buongiovanni, la canzone vide ufficialmente i natali nel 1907. A differenza di molti altri testi digiacomiani, questo non descrive una scena articolata dall’ambientazione ricca e vibrante, ma si focalizza sulla minuscola vicenda di una farfalla che si avvicina troppo alla fiamma di una candela, un’ordinaria tragedia di tutti i giorni che allo sguardo comune passerebbe inosservata, ma che nell’animo sensibile del poeta genera immensa apprensione. Ciò che però non manca a Palomma ‘e notte, nonostante la limitatezza del soggetto, è la profondità simbolica. Nel descrivere il delicato insetto che si ostina a svolazzare attorno alla fiamma nonostante il rischio, ignorando uno dopo l’altro gli accorati avvertimenti della voce narrante e i tentativi di scacciarla, Di Giacomo fa uso di uno stile al contempo vivace e crepuscolare, che rende evidente la sua crescente e frustrata preoccupazione. Il poeta si scotta egli stesso sulla fiamma pur di impedire alla farfalla di autodistruggersi senza ritegno. Il comportamento della farfalla è parallelo a quello di Carolina, la donna e vera protagonista della canzone che continua a sedurre uomini spinta dall’impulso, senza curarsi dei sentimenti del prossimo. Anche per lei, infatti, chiunque cercherà di rimanerle accanto soffrirà per la sua sconsideratezza e sarà alla fine lei a rimanerne vittima. Anche se nel testo viene menzionata un’altra donna, la destinataria del componimento era in realtà Elisa, moglie di Salvatore e donna dal carattere testardo e impetuoso, contrapposto invece a quello fragile e insicuro del poeta. Lui, attanagliato dal dubbio e dalla paura delle conseguenze, cerca di tenere la donna lontana dal suo cuore, ma lei insiste imperterrita nel restargli vicino nonostante le divergenze.
Genesi e retroscena
Alla morte del Di Giacomo, Elisa Avigliano impazzì dal dolore e distrusse tutte le lettere e le poesie che il marito le aveva scritto nel corso della loro relazione. Fortuna volle che la donna dimenticasse un cassetto dove c’erano gli scritti che andavano dal 1906 al 1911. Grazie a queste carte non solo è stato possibile ricostruire la storia del grande e complesso amore tra i due, ma anche trovare il testo originale della poesia. Il testo di Di Giacomo era già stato musicato nel 1907, ma solo grazie a quel ritrovamento fu possibile ricostruire la storia che celava. Elisa era una donna fuori da ogni schema dell’epoca: appassionata, intensa e assertiva, agognava a diventare insegnante per essere indipendente dalla famiglia. Fu in questo periodo, nel 1905, che la giovane conobbe Di Giacomo, di cui era già ammiratrice, alla Biblioteca Nazionale dove lui lavorava; subito se ne innamorò e dopo pochi incontri gli confessò i suoi sentimenti in un’appassionata lettera, altra azione del tutto inaudita per una donna. L’amore tra Salvatore ed Elisa fu travolgente e tormentato. I litigi erano all’ordine del giorno, sia per l’invadenza della madre del poeta sia per le turbe di quest’ultimo, che dubitava della fedeltà della donna. Ciò nonostante, non riuscivano a stare lontani ed erano sempre l’uno al fianco dell’altra nei momenti critici. Il parto creativo di questo testo è stato complesso e si è articolato in più forme in un arco di tempo di almeno quattro anni. La prima volta che queste parole apparvero su carta fu una poesia in dialetto veneto, La pavegia, scritta nel 1904 dalla poetessa armena Vittoria Aganoor Pompilj, che conosceva Di Giacomo e gli ambienti letterari napoletani del tempo; fu infatti quest’ultimo a tradurre la poesia in napoletano con il titolo ‘A farfalla. ‘A farfalla iniziò a prendere la forma di Palomma ‘e notte nel dicembre 1905, quando apparve sulla rivista Pierrot con una nuova struttura, che sarà poi il metro finale. In quell’occasione fu bandito un concorso per musicarla, che portò alla scelta di Francesco Buongiovanni. Salvatore di Giacomo rimase entusiasta della melodia creata dal compositore napoletano, tanto che modificò la seconda strofa, introducendo per la prima volta la simmetria metaforica tra la farfalla e la figura di Carolina. La versione musicata di Palomma ‘e notte fu pubblicata a Piedigrotta nel 1906 e l’anno seguente fu stampata come singolo cantopiano.







